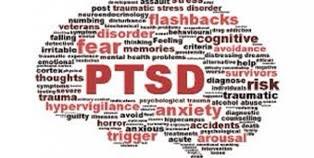Quando si parla di nefasti accadimenti, un acronimo che può venire fuori è quello del PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, una forma di disagio mentale causato da esperienze fortemente toccanti e traumatiche.
Il primo approccio a questo effetto sulla salute mentale risale a studi americani dopo la guerra del Vietnam e agli effetti che quest’ ultima manifestò sui veterani, intorno agli anni 70; da qui il modello venne preso anche per più recenti esperienze belliche ed, in generale, traumatiche.
Manifestazioni del disturbo possono palesarsi da parte di persone di tutte le età: adulti, adolescenti, anziani e bambini così come in testimoni, familiari o soccorritori coinvolti nell’ evento traumatico e non necessariamente in casi di guerra, attentati o esplosioni; il disagio può anche derivare da esposizione a reiterati casi di violenza, degrado o isolamento forzato.
In generale accostarsi a una condizione di stress e determinare la percezione dello stesso è qualcosa di fortemente soggettivo poichè ciò per cui un individuo può sentirsi vulnerabile può essere vissuto con indifferenza o minor coinvolgimento da un altro; una variabile che gioca un ruolo importante è certamente le modalità di trasmissione degli avvenimenti stessi, da qui l’importanza dell’ informazione e dai media, soprattutto su adolescenti, bambini e popolazione debolmente scolarizzata.
Un’ informazione di massa che tende ad utilizzare codici incalzanti può ingenerare sui fruitori sensazioni di ansia o paura che, a causa della non intellegibilità della durata dell’ evento e dei disagi ad esso relativi, come nel caso di una guerra, di una carestia o una pandemia, può anche sfociare in forme di disagio mentale. Il diverso grado di esposizione al trauma è, probabilmente invece, l’aspetto più oggettivo del disagio ed è in grado di spiegare il maggiore o minore “trauma” sulla “vittima”; tanto maggiormente il soggetto è a contatto con il trauma, quanto potenzialmente sarà colpito da postumi a livello psicologico, a breve o a lungo termine.
Le ricerche scientifiche effettuate su diverse aree del cervello dimostrano come le vittime di PTSD producono livelli anomali di ormoni coinvolti nella risposta allo stress e alla paura; centro responsabile di tale procedimento è l’amigdala, una piccola ghiandola situata alla base del cervello che, in situazioni anomale di paura e sensazione di pericolo, si attiva sugli individui affetti da PTSD producendo, per un lasso di tempo superiore alla prassi, molecole di oppiacei deputate a lenire la sensazione di dolore; questa produzione protratta a lungo causa un’ alterazione dello stato emotivo e, talvolta, anche una diminuzione della capacità mnemonica e di apprendimento.
Sebbene il disturbo da PTSD non sia di facile individuazione a causa dell’eterogeneità della sintomatologia che fa riferimento al pregresso del soggetto, elemento come accennato di altissima variabilità, c’è un filo rosso che collega i vari traumi: il rivivere ripetutamente l’esperienza negativa sotto forma di flashback, ricordi, incubi, o in occasione di anniversari o commemorazioni.
I soggetti affetti da tale disturbo manifestano difficoltà a controllare le emozioni, confusione emotiva, insonnia ed ansia, tendenza ad evitare qualsivoglia atto che possa ricondurli a ripercorrere l’evento traumatico ed ipervigilanza, dovuta al fatto di sentirsi ancora in pericolo; inoltre non è raro il senso di colpa per esser sopravvissuti all’evento o non esser stati capaci di salvare altri vicini. Dal punto di vista prettamente fisico alcuni sintomi appurati sono dolori al torace, emicranie, capogiri ed indebolimento del sistema immunitario ma, per appurare un disturbo da PTSD questi sintomi devono persistere per almeno un mese dall’ evento che li ha scatenati.
Non esiste ancora un protocollo sulle metodologie di cure, farmacologiche e psicoterapeutiche, da utilizzare che goda del consenso generale, ma si tende ad affidarsi a terapie del comportamento cognitivo con le quali si tenta di fornire al paziente gli strumenti per la gestione dell’ansia e della tendenza a sotterrare e non affrontare la rielaborazione delle proprie emozioni, anche di gruppo.
La durata del trattamento è di circa 10-12 settimane e prevede il coinvolgimento della comunità di appartenenza e della famiglia, che ricoprono un ruolo chiave nell’approccio; il National Center for PTSD sottolinea, comunque, che la valutazione deve essere totalmente soggettiva e diversificarsi da individuo a individuo, proprio per l’altissima eterogeneità dell’anamnesi psichica nei vari casi.
Oggi nel mondo viviamo giorni particolari, giorni di quarantena mondiale per una Pandemia causata da un virus, il Covid-19, i cui ceppi fanno tanto scervellare gli scienziati e parlare senza sosta i cronisti delle televisioni; strade deserte, relazioni pressocchè inesistenti, nessun abbraccio e paura dell’ inconsapevolezza di come e quando la situazione evolverà.
Non ci sono bombardamenti, né sottomarini e gli aerei, anziché sorvolare i cieli nemici, hanno praticamente smesso di volare; eppure si è parlato di guerra e si è parlato di trincea. Guerra senza armi e trincea domestica o, molto peggio, in ospedale, per medici e pazienti gravemente piegati dal contagio; si è parlato di sacrifici e di indigenza da parte di intere sacche della popolazione, e si parla, soprattutto, di morti. Tutto questo è certamente differente, soprattutto per chi scrive dai tasti di un computer, dalle guerre del passato..ma, purtroppo, e ne siamo certi, causerà e sta già causando un cambio dentro molte vite.